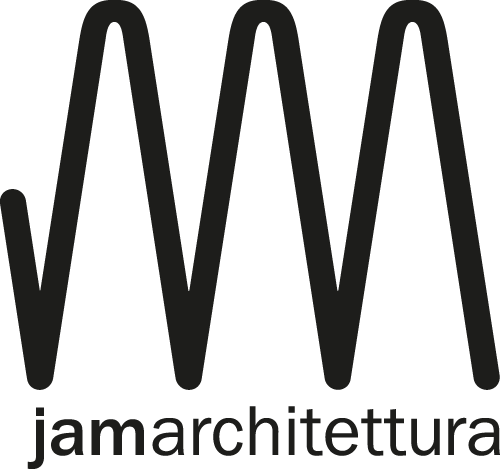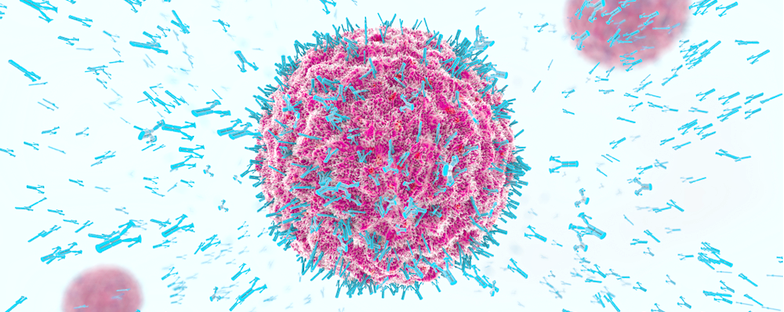PER UN’ARCHITETTURA DE-GLOBALIZZATA
di Jacopo Muzio
Articolo originale https://www.arcipelagomilano.org/archives/55822
Il centro di ricerca per il controllo e prevenzione delle malattie del governo americano ha pubblicato un’indagine epidemiologica su un call center in Corea del Sud, dove si mostra l’evoluzione di un focolaio di Covid 19 scoppiato nei loro uffici situati tra il settimo e l’undicesimo piano di un edificio di diciannove piani con tipica distribuzione a torre – impianti di risalita e servizi al centro, uffici o appartamenti ai lati – dotato di ventilazione meccanizzata e condizionata. Il risultato è che su 1.143 persone che frequentavano il palazzo, testate dopo il primo caso, 97 sono risultate positive e 94 erano sullo stesso piano e nello stesso lato dell’edificio, presumibilmente in prossimità delle loro bocchette di areazione.
In uno sviluppo urbano che vede il netto predominio della progettazione ingegneristica, sia a livello decisionale sia di progettazione (distributiva, strutturale, impiantistica, energetica, ecc.), e una maggior incidenza nei costi di costruzione della voce “impianti”, vincolati da quadri normativi sempre più rigidi e indotti a livello politico da solide realtà produttive, credo che il dato di cui sopra, in epoca di pandemia, meriti qualche riflessione di carattere architettonico in rapporto alla tecnologia.
Abbiamo assistito, e assistiamo sempre più disarmati, al progressivo “space invaders”, anche a Milano, di edifici-frigoriferi, emblemi di un sempre verde stile internazionale, che oltre a soddisfare appieno gli appetiti di una committenza de localizzata e di matrice finanziaria, prevede grandi oggetti: appaganti alla vista, impermeabili verso l’esterno, dotati di funzionali “polmoni meccanici”, con prospetti ripetitivi e scenografici, senza rapporto né con l’intorno né con l’interno, spesso un disarticolato “open space”.
Il non disegno dei prospetti – fedelmente imitato poi dagli studenti di architettura di Milano – si limita a una maglia plasmata da textures superficiali, narrata spesso da ben remunerate pagine di quotidiani nazionali come una generica esaltazione del volume. Niente di nuovo sotto il cielo, le città moderne sono sempre state realizzate da ingegneri, l’architettura è una disciplina relativamente giovane, tuttavia i risultati saranno da giudicare a vent’anni di distanza: architettura è permanenza.
Questi edifici – il più delle volte torri o grattacieli, tipologia idonea alla massimizzazione del profitto nella minor area libera a disposizione – hanno il pregio di essere progetti ad alto contenuto tecnologico clonabili, di poter essere realizzati allo stesso modo ovunque, a Milano come in Corea del Sud o nei deserti dell’Arabia Saudita. Architetture globali, non cercano un dialogo contemporaneo con la storia dei luoghi – che richiede conoscenza, cultura ed anche attori locali – ed esprimono una chiara idea di società, divisa per piani, come le caste: nella giungla metropolitana, sono i dinosauri urbani che meglio si sono adattati alla globalizzazione finanziaria. Dinosauri urbani perché in realtà fanno parte di un modo di progettare risalente alla matrice sviluppista degli anni Venti del secolo scorso, spesso tradotto con una connotazione da provincia dell’Impero.
Eppure, tra tanti pregi, hanno un difetto: si basano completamente sulla tecnologia.
Un black out energetico li rende inservibili, da evacuare. Un virus aggressivo, un microscopico parassita che ha messo in ginocchio la salute e l’economia mondiale, ne mina la salubrità, il primo principio dell’architettura: difendere gli uomini dalla natura esterna e dai loro simili.
Inoltre, se entrasse in crisi il sistema economico della globalizzazione, l’approvvigionamento energetico internazionale, la capacità produttiva e di trasporto di elementi prefabbricati in altre parti del mondo, poi qui assemblati, data la natura sovra dimensionata di questi edifici, nessuno se ne farebbe carico e sarebbe impossibile la loro manutenzione. Sono edifici nati in tempi di pace, figli di una generazione del boom economico poco previdente e di un capitalismo aggressivo, che vede l’architettura come un prodotto, una sommatoria di marchi da far consumare agli utenti, ex abitanti declassati, senza spazio per il genius loci, la dimensione anche artigianale del manufatto edilizio e l’orizzonte sociale del fare architettura.
Non basteranno filtri o sostituzioni di costose macchine areanti per ritrovare un equilibrio con l’interrotto dialogo tra la storia dei luoghi e l’architettura, fotografia di ogni epoca; per stabilire un punto d’incontro tra la società, la geografia e ad esempio il disegno delle soglie degli edifici, che modulano il rapporto tra interno ed esterno, dando peculiarità e identità ai luoghi, rendendoli attrattivi. Se un eccesso di tecnologia può recare danno agli abitanti, vanno ripensati il modo di progettare e i processi produttivi di tanti uffici, negozi, case, centri medici, aule, mezzi di trasporto, fabbriche … c’è spazio per una nuova architettura de-globalizzata.
Prima regola della robotica: un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, un essere umano riceva danno. (Isaac Asimov)